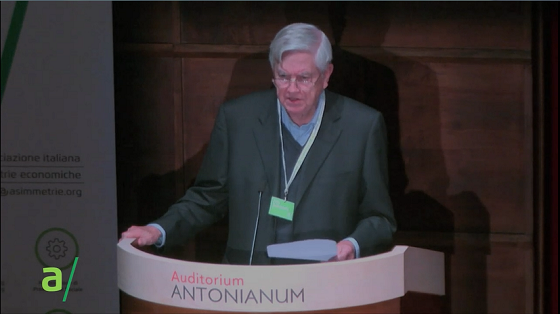Nel suo libro Ripensare l’unione dell’Europa, Giandomenico Majone sorride all’idea che si sia potuto credere di esorcizzare il demone del nazionalismo creando una supernazione europea. Ora che il progetto mostra la corda, l’illogica europea fa un ulteriore passo avanti: “Non possiamo rimediare all’errore compiuto”, ci viene detto, “anzi, dobbiamo perseverare, restando nell’euro, perché se uscissimo nessuno sa cosa succederebbe, ma sarebbe un disastro”. Ora, i casi sono due: o non sai cosa succederà, e allora studi; o sai che sarà un disastro, ma allora devi spiegarci bene il perché.
L’onore della prova infatti cade sui catastrofisti, poiché l’evidenza storica è contro di loro. Lo studio più autorevole sulla dissoluzione di unioni monetarie, condotto da Andrew Rose all’Università della California, chiarisce che nei 69 casi verificatisi nel dopoguerra “non si registrano movimenti macroeconomici violenti prima, durante o dopo un’uscita”. Ripetere “non sappiamo cosa succederà ma sarà un disastro” appare un espediente per sottrarsi alla sfida dei dati. Chi scrive ha deciso di accettare questa sfida, iniziando un percorso di studio insieme agli altri economisti firmatari del Manifesto di solidarietà europea, col quale proponevamo nel 2013 quanto oggi consiglia Joseph Stiglitz: lo smantellamento controllato dell’Eurozona. Sono stati tre anni di studio faticoso, ma che ci consente di mettere a fuoco le effettive criticità di un’uscita.
Prendiamo ad esempio il tema del debito pubblico. Quello italiano è pari a 2.171 miliardi (dati di fine 2015), di cui circa un terzo (740 miliardi) in mano estera. Se adottassimo una nuova valuta nazionale, svalutandola ad esempio del 20%, rimborsare quei 740 miliardi, si dice, costerebbe il 20% in più. Il governo dovrebbe cioè reperire, oltre al resto, l’equivalente di 148 miliardi di euro: più di cinque manovre finanziarie! Questo ragionamento ignora il principio della Lex monetae, sancito negli articoli 1277 e seguenti del Codice civile: uno stato sovrano può stabilire in quale moneta debbano essere estinte le obbligazioni regolate da legge nazionale. L’elemento determinante non è la nazionalità dei contraenti, ma quale diritto (nazionale o estero) regoli il contratto. Quindi se un tedesco detiene un Btp emesso sotto legislazione italiana, dovrà rassegnarsi a essere rimborsato in valuta nazionale svalutata.
Succede ogni giorno sui mercati: pensate agli investitori che avevano titoli denominati in sterline prima della Brexit (in seguito alla quale la sterlina si è svalutata del 15%). Viceversa, se il titolo è emesso sotto legislazione estera dovrà essere rimborsato nella valuta prevista dal contratto (verosimilmente euro), perché il governo italiano non può ri-denominare nel nuovo conio un contratto che non cade sotto la sua giurisdizione.
In Costs and benefits of Eurozone breakup uno degli autori di questo articolo ha calcolato la percentuale di debito pubblico sotto legislazione estera: solo il 6% di quello in mano estera, ovvero 44 miliardi di euro. Una svalutazione del 20% aggraverebbe quindi di soli 9 miliardi il rimborso del debito pubblico: un impegno sostenibile. Il vero problema è altrove, nel grande assente dal dibattito: il debito privato.
Qui le cose vanno diversamente: dai dati Bloomberg risulta che circa la metà delle obbligazioni private siano under foreign law, cioè governate da diritto estero. Il centro studi a/simmetrie valuta che alla fine del 2014 il totale di debiti non ridenominabili (cioè da rimborsare in valuta forte) fosse pari al 46% del Pil. Un valore non trascurabile ma nemmeno catastrofico. Intanto, in questa classifica l’Italia è seconda solo alla Germania: tutti gli altri paesi dell’Eurozona hanno esposizioni verso l’estero maggiori, con una media del 102% del Pil.
In questo senso l’Italia conferma di essere un paese relativamente solido, nonostante l’avviso dei media italiani. Le esperienze storiche mostrano che quando il debito non ridenominabile supera il 30% del Pil, una svalutazione può compromettere la situazione finanziaria delle imprese, causando recessione. Questi studi rischiano però di essere pessimistici, perché riferiti per lo più a paesi emergenti, i cui mercati finanziari poco sviluppati non offrivano strumenti di copertura dal rischio di cambio (i derivati nascono a questo scopo), e il cui settore privato non aveva rilevanti attività in valuta pregiata.
La situazione italiana è diversa: lo dimostra il fatto che nel 1992 una svalutazione del 20% non provocò alcuna ondata di fallimenti (mentre in Thailandia nel 1997 l’impatto fu più duro): ora come allora gli italiani, oltre ai debiti, hanno anche crediti under foreign law, e anche questi ultimi si rivaluterebbero in caso di svalutazione. In ogni caso, il vantaggio principale dell’uscita dall’euro è proprio quello di passare da una situazione dove per ricapitalizzare le banche occorrerà rivolgersi alla Troika, a una situazione in cui la banca centrale nazionale può disporre linee di credito di emergenza in valuta nazionale per rifinanziare imprese in temporanea situazione di stress. Insomma: cosa succederà, certo, non lo sa nessuno, ma parlare di catastrofi epocali per rifiutarsi di analizzare la realtà non aiuta a minimizzare i costi di una eventuale uscita (voluta o subita), individuando e gestendo razionalmente le vere priorità.
Alberto Bagnai
Jens Nordvig
Il Fatto Quotidiano, 19 ottobre 2016