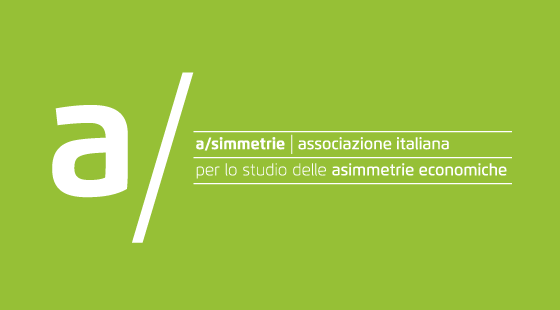Fabio Scacciavillani ha lanciato dalle colonne di questo giornale un dibattito sul tema della “stagnazione secolare”: la tesi, proposta da Alvin Hansen negli anni Trenta e ripresa recentemente da Larry Sanders, secondo cui le fonti della crescita economica sarebbero inaridite per cause di natura strutturale, epocale, e in quanto tali sostanzialmente indipendenti dalle scelte di governo dell’economia.
Già il fatto che questa tesi si ripresenti ciclicamente fa intuire che forse non è del tutto fondata. Personalmente la ritengo un capro espiatorio per governi tanto incapaci di fare gli interessi della maggioranza, quanto capacissimi di fare quelli di minoranze conniventi. Tuttavia l’articolo di Scacciavillani pone domande stimolanti, alle quali può essere utile dare una risposta.
In particolare, vorrei “mettere a sistema” la seconda e la settima domanda: “l’abnorme crescita del debito è stato un modo per perpetuare il miraggio della crescita reale?”, e: “le disuguaglianze di reddito e di ricchezza costituiscono un freno alla crescita?” Alla seconda domanda possiamo rispondere senz’altro di sì, e la spiegazione passa per la prima domanda. La disuguaglianza, in particolare quella di reddito, nel lungo periodo danneggia la crescita, perché costringe a un numero sempre più ampio di agenti economici a finanziare le proprie spese con debito (visto che i redditi percepiti sono insufficienti), aprendo la strada a crisi finanziarie dagli effetti depressivi, come quella attuale.
La crescita abnorme del debito, evidenziata da Scacciavillani (e anche dai dati) ha quindi origine non in un improvviso accesso di sfrenata lussuria consumistica collettiva, ma nella vera stagnazione secolare: quella dei salari. Come evidenziano ormai numerosi studi (fra i più completi quello di Ishac Diwan, funzionario della Banca mondiale e insegnante a Harvard), dalla fine degli anni ’70 in poi i salari reali (cioè corretti per l’inflazione) sono fermi. Lo stesso non è accaduto alla produttività, che si è mantenuta sul trend di crescita dell’ultimo secolo e mezzo (circa il 3% all’anno). Da quarantanni a questa parte, lavoratori che ogni anno producono di più (a causa del progresso tecnologico e della migliore formazione) ricevono lo stesso potere d’acquisto. Mentre il prodotto aumentava, ai salari andava una fetta progressivamente minore. Dato che i salari, di norma, sono la retribuzione dei meno ricchi, questo significa che i poveri sono diventati più poveri, e i ricchi più ricchi.
Già negli anni ’80 Augusto Graziani faceva notare come in queste condizioni fosse giocoforza finanziare la domanda di beni e servizi con debito, in particolare pubblico. Un debito del quale gli imprenditori già allora si lamentavano, ipocritamente (sosteneva Graziani), perché senza la liquidità immessa nell’economia dallo Stato con la spesa in deficit, il sistema sarebbe collassato.
Negli anni ’90, poi, la progressiva liberalizzazione dei mercati ha permesso agli sconfitti del conflitto distributivo di finanziarsi sempre e più facilmente presso le istituzioni finanziarie private: mentre il debito pubblico veniva derubricato a fonte di ogni male, quello privato era acclamato come “innovazione finanziaria”, e i cartelli pubblicitari ci esortavano “prendi oggi e paga fra un anno!” Il capitalismo finanziario è quello in cui il cliente, per essere tale, deve diventare debitore: ma questa montagna di debito privato, purtroppo, è intrinsecamente soggetta a periodiche frane. Cristiano Perugini e i suoi coautori hanno confermato nel 2015 sul «Cambridge Journal of Economics» il nesso fra disuguaglianza e crisi finanziarie. D’altra parte, siccome “i sacrifici vanno fatti fare a chi ci è abituato” (come diceva il Cipputi di Altan), se la disuguaglianza porta alle crisi finanziarie, queste portano a ulteriore disuguaglianza.
Lo studio di Diwan mostra come ovunque nel mondo le crisi vengano gestite col “Fate presto!” di infame memoria (ricordate le riforme di Monti e Fornero?): il tentativo del capitale di appropriarsi di una fetta ancora più grande di una torta sempre più piccola, giustificando questo esproprio con la retorica dell’emergenza. Nelle crisi dei ricchi solo i poveri piangono: lo confermano anche Davide Furceri e Prakash Loungani del Fmi, notando come la liberalizzazione finanziaria, che in teoria avrebbe dovuto portare a una condivisione del rischio fra risparmiatori di più paesi, in pratica si è tradotta in un sistema dove il rischio è assorbito dai più poveri. Un rischio, si noti, al quale non è associato né un particolare rendimento, né una particolare crescita, perché i debiti vengono contratti non per effettuare investimenti produttivi, ma perché incitati da un sistema bancario saturo di liquidità (come nel caso dei mutui subprime americani).
L’equilibrio è quindi instabile: più disuguaglianza implica più crisi che implicano più disuguaglianza, in un contesto di stasi dei salari e di bonus milionari al management, mentre l’accresciuta disuguaglianza frena la crescita perché convoglia minor reddito verso le classi meno abbienti, quelle che avrebbero una maggiore propensione a spenderlo, riattivando l’economia. La risposta alle domande di Scacciavillani porta quindi con sé un’altra domanda, quella cruciale: cosa ha causato la vera stagnazione secolare, quella dei salari? Lascio questa domanda a chi vorrà raggiungerci nel dibattito.
Alberto Bagnai
Il Fatto Quotidiano, 4 maggio 2016