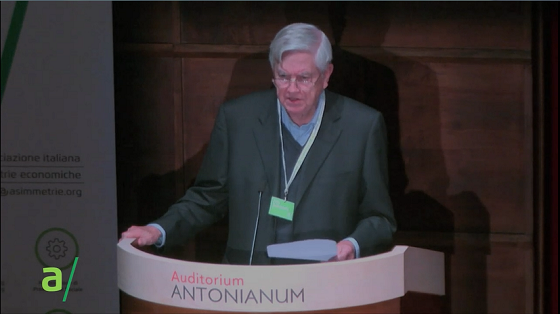In fondo non c’è nulla di nuovo nella manovra di politica economica delineata dal Governo nel Documento di programmazione finanziaria per il 2018. È la continuazione della politica economica condotta negli ultimi quattro anni sotto l’occhio apparentemente severo, ma sostanzialmente accondiscendente, delle autorità europee. Lo sforzo del Governo, ancora una volta, è quello di attenuare le richieste di austerità, non di rifiutarle. Il che ha significato e significa che la crisi italiana è destinata a continuare.
Nel Documento, il Governo prevede un deficit di bilancio in calo nel 2018 rispetto al 2017 e una riduzione, ancorché modesta, del rapporto fra il debito pubblico e il reddito nazionale. Dunque la politica economica rimane sostanzialmente restrittiva. Non vi sarà alcuno stimolo alla ripresa economica derivante dalle condizioni della finanza pubblica. Il Governo spera che a fine anno, avvicinandosi il momento delle elezioni politiche in Italia, la Commissione di Bruxelles possa chiudere un occhio sul rallentamento del percorso di rientro ripetutamente concordato con l’Italia e regolarmente disatteso. Ma non si tratterà per ottenere l’autorizzazione ad immettere risorse aggiuntive per il sostegno della ripresa: si tratterà soltanto per ottenere un grado minore di restrizione. Con l’occhio rivolto alle elezioni e non al futuro del Paese non si va lontano.
Sappiamo – e dovrebbe ormai saperlo anche il Governo – che questa politica non ha prodotto alcun risultato in questi anni. Se così non fosse, l’Italia non sarebbe il fanalino di coda della crescita fra tutti i paesi dell’euro. I timidi cenni di ripresa vengono solo dalle più favorevoli condizioni di competitività internazionale dovuta alla flessione delle quotazioni dell’euro rispetto al dollaro che hanno consentito una modesta ripresa delle esportazioni. Ma non ci sono nuovi investimenti privati – come testimoniano le informazioni sulla domanda di credito che provengono dal sistema bancario – e soprattutto non ci sono investimenti pubblici, poiché lo sforzo del governo di non incidere sulle prestazioni sociali fa sì che la riduzione del deficit avvenga soprattutto tagliando le spese in conto capitale.
È mancata, fin dall’inizio della legislatura che ora sta per concludersi e soprattutto fin dall’inizio del governo Renzi, che pure dichiarava di voler cambiare profondamente le carte in tavola, un’analisi di fondo delle condizioni del nostro Paese. Non ci si è chiesti quali fossero le cause della sconcertante apatia in cui il sistema economico italiano è caduto dal molti anni. Non si è contestata la tesi di fondo che promanava e tuttora promana da Bruxelles e da Berlino che ciò che frena la crescita italiana è il nodo della finanza pubblica e che dunque questo era il problema da aggredire. Ci si è limitati a pretendere – o a implorare – dosi meno massicce della medicina, non a contestare la diagnosi.
La Germania, negli anni del Cancellierato Schroder, mentre introduceva riforme del mercato del lavoro, portava il deficit ben oltre il 3% per compensare gli effetti collaterali di quella manovra. Gli Stati Uniti sono usciti dalla crisi del 2008 alzando senza esitazioni il deficit pubblico ed aggiungendovi una politica monetaria particolarmente generosa. Altri paesi europei – come la Spagna e l’Irlanda – hanno aumentato enormemente il debito pubblico per salvare dalla crisi il sistema bancario e, in Spagna, il settore edilizio che era in piena crisi. Perfino la Francia ha testardamente mantenuto il proprio deficit sopra il 3%, nonostante gli impegni e gli obblighi del Patto di Stabilità.
L’Italia ha alzato la voce, e non per una politica diversa, ma per una politica di austerità un po’ meno rigida. Traiamo i benefici minimi dalla svalutazione dell’euro e dalla politica monetaria della Banca Centrale Europea.
Era troppo sperare in un cambiamento radicale di impostazione da parte di un Governo che è in sostanziale continuità con quello che lo ha preceduto? Ma così alla prossima legislatura si lascia un’eredità terribile: un’economia che non dà segni di ripresa degli investimenti, un Mezzogiorno prostrato dalla disoccupazione, le famiglie che continuano a guardare con ansia al futuro e quindi tendono a risparmiare più di quanto sarebbe sano per il Paese ed un debito pubblico che in rapporto al PIL continua a crescere. Il sospetto che è divenuta certezza è che nel Governo non vi è un’idea di come operare per fare ripartire l’economia italiana.
Da dove si dovrebbe ripartire? Bisogna rovesciare il ragionamento. Abbandonare del tutto l’impostazione europea e chiedersi semplicemente e direttamente che cosa si deve fare per fare risalire il tasso di crescita dell’economia italiana dallo 0-1 per cento di questi anni al 3% di cui avremmo bisogno. Questa analisi porta a una semplice risposta: senza uno stimolo proveniente dalla finanza pubblica attraverso un minore prelievo fiscale sui redditi e senza maggiori investimenti pubblici l’economia italiana non può ripartire e non ripartirà. Bisogna calcolare quale deficit serve per consentire la crescita dei consumi e il rilancio degli investimenti pubblici. Il Governo dovrebbe prendere una chiara decisione in questo senso e scriverlo nei suoi Documenti finanziari.
Fatto questo, si tratterebbe di discutere con l’Europa quali contropartite essa vede necessarie per acconsentire a questa politica. Maggiore privatizzazione per ridurre una tantum il debito pubblico? Si può fare. Riforme più coraggiose dei mercati per favorire la concorrenza? Si può fare (lo stop al ministro Calenda su questi temi è un tragico errore). Una revisione non marginale della struttura del bilancio pubblico di parte corrente? Sarebbe la benvenuta anche per noi. Ma tutto questo richiede uno stato d’animo diverso, meno rassegnato, più propositivo. Sarebbe stato un bel segnale di discontinuità se nel Documento di programmazione finanziaria tutto questo fosse stato delineato. Così non è. Un’occasione perduta. Bisognerà riparlarne seriamente fra qualche mese.
Giorgio La Malfa
Il Mattino, 14 aprile 2017