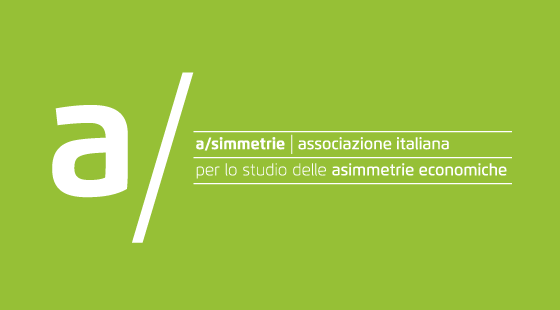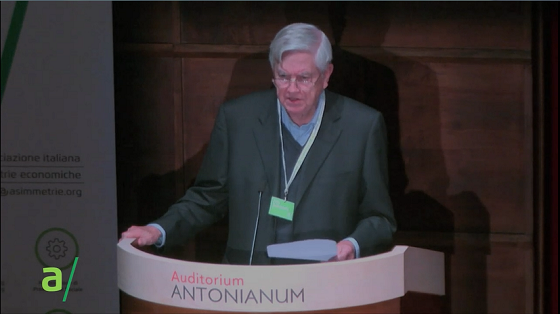La settimana scorsa è accaduto l’inaspettato: nello schieramento progressista si è finalmente aperto un dibattito sull’euro. Lo ha promosso involontariamente Giorgio Lunghini, scrivendo per Il Manifesto un pezzo nel più puro stile catastrofista, quello a cui ci hanno abituato, negli ultimi anni, gli economisti Giannino e Barisoni, prima di avere un problema più urgente di cui occuparsi: il dissesto del gruppo editoriale per il quale lavorano. Sospetta è questa corrispondenza di amorosi sensi fra intellettuali di sinistra e opinionisti organici al capitale, che pure si era manifestata in passato, passando per lo più sotto silenzio. Ma a settembre 2016, è ormai chiaro quanto preconizzavo su queste colonne il 25 giugno scorso parlando di Brexit: certi scenari apocalittici sono destinati a rivelarsi infondati, screditando la scienza economica. Forse per questo sei economisti (Cesaratto, D’Antoni, Giacché, Nuti, Pini e Stirati), con una scelta coraggiosa, hanno replicato dati alla mano per chiarire la totale infondatezza dello scenario di Lunghini, secondo cui l’uscita dell’Italia dall’euro causerebbe un crollo del Pil superiore a quello determinato dal Secondo conflitto mondiale. Si è aggiunto al dibattito Carlo Clericetti, chiedendosi nel suo blog Soldi e potere perché un economista autorevole sia intervenuto “sparando cifre a casaccio”.
In realtà le cose stanno un po’ peggio di così. Il 6 settembre 2011, l’Unione Banche Svizzere (Ubs) emise un documento su “Le conseguenze della rottura dell’euro”. Privi di comprovata esperienza di ricerca, i tre autori asserivano che l’uscita dall’euro sarebbe costata agli abitanti di un Paese in crisi fra i 9.500 e gli 11.500 euro a testa nel primo anno. Dato che nel 2010 il Pil pro capite degli italiani era di 27.583 euro (nel 2015 è sceso a 26.915), gli 11.500 euro di perdita millantati corrispondevano al 40% di recessione “nel primo anno” di cui parla Lunghini. Lo scopo di questo affresco a tinte fosche si palesava nell’ultima frase: “L’unico modo per garantirsi dal rischio di rottura dell’euro è non investire i propri risparmi in euro”. Tradotto: sarà un disastro, quindi portate i soldi in Svizzera, magari all’Ubs. I tre, insomma, erano in plateale conflitto di interessi e il loro sedicente studio era semplicemente pubblicità, peraltro inefficace: poco dopo infatti l’Ubs dovette licenziare 10 mila dipendenti…
Nel frattempo, però, questo documento era diventato la bibbia di Squinzi. Il presidente di Confindustria lo citava a spron battuto, direttamente, o per interposto opinionista, mostrando un certo sprezzo del pericolo: i licenziamenti Ubs avevano già dimostrato come in economia improvvisare porti sfortuna, e la vicenda del «Sole 24 Ore» oggi lo conferma. Da anni cerco di far riflettere (anche) la sinistra su un dato incontrovertibile, quello che Stiglitz buon ultimo illustra nel suo libro, e che Peter Gomez ha espresso lunedì scorso a Coffee Break in termini lapidari: “Non potendo più svalutare la moneta, si svaluta il lavoro”. Come ammette la stessa Commissione europea (nel rapporto “Occupazione e sviluppo sociale in Europa” del 2013), la svalutazione interna, cioè il taglio dei salari, scelta che la rigidità del cambio rende obbligata, è causa prossima dell’aumento di disoccupazione e disuguaglianza: due cose non proprio “di sinistra”. Ora che l’esile fiammella di un dibattito si è accesa, non è certo mio interesse estinguerla con un secchio d’acqua gelata. Tuttavia, registro con sconforto come i progressisti abbiano smarrito la nozione di materialismo storico.
Un economista che, come Lunghini, si richiama al pensiero classico e marxista, nel momento in cui usa gli argomenti di uno Squinzi, prima ancora di chiedersi se sono corretti, dovrebbe chiedersi quali interessi stia difendendo. Come fa Lunghini a non vedere il conflitto d’interessi del dépliant a cui si ispira? E come fa a credere che gli interessi di Confindustria, della quale ricalca gli “argomenti”, coincidano con quelli dei lavoratori? Chi, come Squinzi o Lunghini, paventa inflazioni a due cifre, se vuole apparire credibile deve spiegarci perché, a fronte di una svalutazione dell’euro pari al 20% fra 2014 e 2015, oggi siamo in deflazione. Nei miei testi questo paradosso è spiegato. Agitare lo spauracchio dell’inflazione ha effetti politici devastanti: suggerisce l’idea che la migliore tutela del potere d’acquisto dei lavoratori non venga da un sindacato che difenda questi ultimi, ma da una Banca centrale indipendente (da chi?) che controlli i prezzi. Eppure, oggi dovrebbe essere facile rendersi conto del fatto che la fittizia indipendenza della banca centrale sancisce la definitiva chiusura di qualsiasi spazio di democrazia: non basta l’esempio della Grecia?
Ed è ormai chiaro che l’inflazione non si controlla lesinando la moneta, ma lasciando la gente a casa. Si chiama esercito industriale di riserva, e Lunghini lo ha sicuramente incontrato, sui libri. Dubito però che lo abbia incontrato di persona: la sua richiesta di chiarirgli i vantaggi di un’uscita dall’euro dimostra infatti che lui, come del resto chi scrive, rientra fra chi non è stato ancora lambito dagli svantaggi dell’entrata. Tanto meglio, ma ora, forse, ci conviene cominciare a ragionare serenamente sugli scenari che ci attendono. Teoria e fatti dimostrano che nessuno è al riparo. Dopo, sarà tardi.
Alberto Bagnai
Il Fatto Quotidiano, 5 ottobre 2016