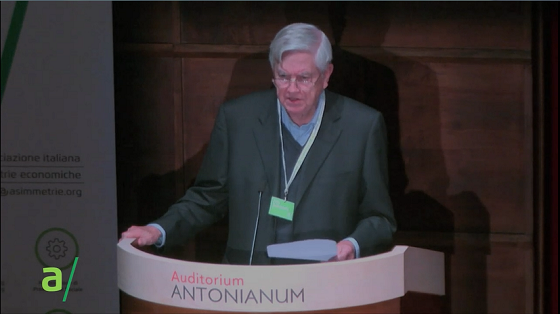Di Alfredo D’Attorre
Deputato del Partito Democratico
Membro della Commissione Affari Costituzionali
Muoverò da una premessa non formale: il tema posto al centro del convegno, la ricostruzione del ruolo dello Stato, è davvero quello cruciale per la sinistra europea. La scelta di questo argomento è in sé tutt’altro che neutra o innocente. Solo qualche anno fa essa sarebbe stata difficilmente pensabile, anche in un convegno e in una cerchia di intellettuali che si propongono di «ripensare la sinistra». Fino alla cesura rappresentata dalla crisi economica globale, una visuale del genere sarebbe immediatamente apparsa retrograda, destinata a subire l’accusa di statalismo e di nostalgia per un passato ormai irrimediabilmente trascorso. E questo sarebbe accaduto sia in ambiti più orientati verso la sinistra riformista, sia in settori più vicini alla sinistra cosiddetta ‘radicale’ o ‘antagonista’, che in taluni casi (si pensi solo all’influenza dei lavori di Negri e Hardt) si erano spinti molto più avanti sulla strada di un felice congedo dalla statualità novecentesca e dell’illusione di cavalcare l’onda della globalizzazione in chiave emancipativa.
Proverò schematicamente ad argomentare la tesi che riaffermare la necessità di ricostruire lo Stato significa prendere di petto la questione centrale del disarmo politico e culturale della sinistra nell’ultimo trentennio. Il corollario di questa tesi è che lo stesso argomento specifico di questa sessione, la crisi della rappresentanza democratica e il necessario ripensamento delle sue forme sociali e istituzionali, non può essere disgiunto dal processo di destrutturazione della statualità.
L’avvio di questo percorso va individuato alla fine degli anni settanta, quando inizia progressivamente a formarsi un dispositivo ideologico che coniuga elementi interconnessi su piani diversi. Ne enucleo i tre principali: sul piano politico la cosiddetta rivoluzione ‘neo-conservatrice’ che si impone a partire dai paesi anglosassoni, sul terreno economico il prevalere del monetarismo neo-liberista, a livello di teoria sociale l’affermarsi di una specifica lettura in senso anti-statuale della globalizzazione contemporanea. Secondo questa visione, essa non costituisce semplicemente una tra le diverse fasi di internazionalizzazione degli scambi e dei commerci, come altre ve ne sono state nella storia economica moderna, ma segna piuttosto una vera e propria soglia epocale. La natura di questa discontinuità storica non è limitata al solo ambito della produzione e dei commerci, ma implica niente di meno che il tramonto delle istituzioni politiche e giuridiche della modernità, imperniate sulla figura dello Stato sovrano.
È interessante osservare come questa lettura della globalizzazione in chiave di tramonto irreversibile della statualità moderna diventi una sorta di communis opinio nel campo della riflessione teorica, anche da parte di studiosi non sospettabili di simpatie liberiste o neo-conservatrici. In ampi settori dell’intellettualità progressista diventa senso comune che si stia entrando in un’età felicemente post-moderna e post-statuale. Un nuovo costituzionalismo globale, fondato sul primato delle corti e sull’interazione virtuosa fra diritto ed economia globale, avrebbe garantito i diritti umani (compresi quelli sociali!), oltre le barriere e i vincoli dello Stato sovrano. Oggi, dopo la lezione della grande crisi globale, può sembrare un’amenità, ma fino a qualche anno fa era piuttosto diffusa l’idea che lo smantellamento dei poteri di intervento e lo svuotamento della sovranità degli Stati nazionali potesse racchiudere in sé nuove potenzialità partecipative ed emancipative per il cittadino globale.
Questa visione, che in realtà celava un preciso apparato ideologico, ha segnato in profondità la costruzione dell’Unione Europea e il discorso pubblico sui caratteri che essa avrebbe dovuto assumere. Il rifiuto del cosiddetto ‘super-Stato’ è diventato un leit-motiv non solo dei conservatori anti-europeisti, ma anche dei progressisti favorevoli al proseguimento e al rafforzamento dell’integrazione europea. Il punto di convergenza è stato che questa integrazione in nessun caso avrebbe potuto o dovuto portare l’Europa a costruire una statualità federale riconducibile ai modelli storici esistenti. È la tesi del «Sonderweg» europeo, secondo la formula adoperata dal giurista Joseph Weiler all’inizio degli anni novanta e poi riproposta con innumerevoli variazioni attorno alla stessa idea centrale da una miriade di studi politologici, giuridici, filosofico-politici, centrati sull’irriducibile specificità storica della costruenda forma istituzionale dell’Unione Europea. Secondo questa visione, diventata assolutamente egemone sia nel dibattito teorico sia nelle posizioni politiche delle forze progressiste, il fatto che l’Unione Europea escludesse qualsiasi evoluzione verso la forma statuale e al tempo riducesse fortemente le prerogative sovrane degli stati membri, affidandole a una sempre più spesso evocata quanto indefinita «multilevel governance», non rappresentava un problema o un rischio, quanto piuttosto il segno del carattere innovativo e ‘post-moderno’ del cantiere istituzionale aperto nel Vecchio Continente. Un esperimento che veniva offerto come un modello al resto del mondo, in quanto più adatto ad affrontare le sfide della globalizzazione rispetto alle aree che restavano ancorate alle forme e ai vincoli otto-novecenteschi della sovranità statuale su base nazionale. In questo quadro, l’euro, la prima moneta senza Stato, appariva come il progetto più ardito e paradigmatico dell’Europa come potenza post-statuale.
L’esplosione della crisi globale nel 2008 segna il brusco risveglio da queste illusioni. Dappertutto l’uscita dal collasso finanziario avviene per effetto dell’azione decisiva degli Stati sovrani e delle loro banche centrali, attraverso le quali si esercita uno degli elementi fondanti della sovranità, il controllo della moneta. Laddove questo non avviene per effetto dei caratteri peculiari e ‘post-moderni’ della costruzione europea, ovvero nell’area dell’euro, l’esplosione della bolla finanziaria si trasforma in una lunga recessione di cui ancora oggi non si vede la fine. La crisi globale si trasforma nel giro di pochi anni in una crisi dell’euro. Altro che modello post-sovrano da offrire al resto del mondo come esempio virtuoso di adattamento alla globalizzazione: al primo vero appuntamento con la storia, ossia con la necessità di una decisione politica in senso alto, il modello di integrazione dell’Unione Europea, sviluppato dopo la cesura del 1989 a partire dal Trattato di Maastricht, rivela tutta la sua fragilità e impotenza. Inizia a essere evidente (almeno per chi vuol vedere la realtà delle cose libero dal condizionamento dei corposi interessi che sostengono il mainstream ideologico) in quale pasticcio ci sia cacciati avendo imbrigliato e disarmato gli Stati nazionali senza costruire una sovranità politica a livello di eurozona.
L’esperienza di questi anni ci dice che, in realtà, il tramonto della statualità, di cui si è parlato e scritto per un trentennio sotto l’interessato impulso dell’egemonia culturale liberista e globalista (e sarebbe forse il caso di riflettere sulle neppure troppo nascoste affinità elettive tra questi due indirizzi), si riduce sul piano storico concreto a una ben più determinata crisi degli Stati nazionali europei, in particolare di quelli che si sono vincolati al progetto dell’euro. Una crisi che deriva da una drastica auto-limitazione delle prerogative sovrane, a partire da quelle decisive della moneta e del bilancio, con tutte con le conseguenze che ciò ha prodotto in termini di svuotamento della decisione democratica.
Qualsiasi discorso sulle difficoltà e sulle trasformazioni della rappresentanza che non tenga conto di questa strutturale limitazione dei poteri di decisione della sovranità popolare nella costruzione europea rischia di non afferrare l’essenziale. In una delle precedenti relazioni, Carlo Galli ha opportunamente sottolineato il legame costitutivo fra funzione dei partiti politici e forma statuale. La democrazia dei moderni non può che fondarsi sulla logica di funzionamento della politica moderna. Lo hanno spiegato in formule rimaste celebri i classici della riflessione giuridica e sociologica sulla Stato moderno: lo ha fatto Jellinek affermando che il concetto stesso di ‘politico’ presuppone il concetto di ‘statuale’, lo ha ribadito Weber definendo il fine specifico di ogni agire propriamente politico come diretto a concorrere alla direzione di uno Stato. I partiti politici nascono e si sviluppano entro questo orizzonte storico e teorico. È impensabile che possano esistere partiti vitali in uno Stato dimidiato, svuotato di una parte essenziale della sua sovranità decidente.
La parabola della cosiddetta Seconda Repubblica italiana è da questo punto di vista esemplare. L’adesione al Trattato di Maastricht e al percorso verso la moneta unica, con i vincoli finanziari stringenti che essa determina, è uno dei fattori decisivi che accelera la decomposizione del vecchio sistema partitico. L’ingegneria elettorale e istituzionale prende il posto di un ripensamento in termini sociali e culturali della funzione dei partiti. In assenza di ciò, si apre la via a una presidenzializzazione di fatto del sistema politico, in maniera esplicita a livello locale con l’elezione diretta dei sindaci e dei governatori regionali, in maniera surrettizia a livello nazionale con la finzione dell’elezione diretta del premier e il meccanismo tutto italiano del maggioritario di coalizione, che svilisce autonomia e soggettività dei partiti politici costringendoli dentro aggregazioni elettoralistiche costruite al solo fine di aggiudicarsi il premio di maggioranza. Si comprime la capacità di rappresentanza reale del pluralismo politico a favore della concentrazione e della personalizzazione del potere in capo al sindaco, al governatore, al premier, dentro un assetto istituzionale sprovvisto a tutti i livelli dei contrappesi e della tutela del ruolo delle assemblee elettive propri di un vero sistema presidenziale. La spinta alla concentrazione e alla personalizzazione del potere si configura come una sorta di reazione compensativa rispetto allo svuotamento in termini reali del potere democratico.
In Italia è piuttosto evidente il rischio di accentuare questa deriva con le attuali riforme proposte in campo istituzionale ed elettorale. Allo stesso tempo, non affiora nessuna consapevolezza che la cosiddetta crisi della rappresentanza abbia radici più profonde della semplice usura o presunta inadeguatezza di alcuni meccanismi istituzionali. Mario Dogliani ha richiamato la perdita di prestigio e di credibilità delle istituzioni parlamentari. Sarà senz’altro giusto riformare il bicameralismo italiano e semplificare il procedimento legislativo, ma c’è davvero qualcuno disposto a credere che il discredito del Parlamento dipenda dal fatto che le leggi debbano essere approvate in doppia lettura dalla Camera e dal Senato, e non piuttosto dalla percezione diventata senso comune che il Parlamento non è più in larga parte il luogo di espressione della sovranità popolare, in quanto lo Stato democratico è stato svuotato di una quota essenziale dei suoi poteri a favore di organi tecnocratici nazionali e sovranazionali? Giusto allora razionalizzare il bicameralismo, rimettere in ordine il Titolo V, approvare una legge elettorale che ricostruisca un equilibrio decente tra rappresentanza e governabilità. Confesso però il mio radicale scetticismo sulla possibilità che anche una buona ingegneria costituzionale possa incidere sullo svuotamento sostanziale della sovranità democratica e sugli effetti che esso produce nel rapporto tra rappresentanti e rappresentati.
Se vogliamo davvero affrontare il tema della rappresentanza e farlo dal punto di vista di una sinistra che voglia rimettere radici autonome nella società, dobbiamo riconoscere il bivio fondamentale di fronte al quale ci troviamo. Esso è posto dalla domanda su come si scardina l’attuale assetto europeo, della cui insostenibilità occorre ormai prendere atto sotto due profili essenziali. Da un lato, sul piano politico, una democrazia svuotata e de-sovranizzata, la quale come reazione tende a produrre contraccolpi anti-europeisti sempre più forti, ormai difficili da contenere e liquidare con la categoria onnicomprensiva di populismo. Dall’altro, sul piano economico-sociale, la recessione, l’impoverimento e la disoccupazione crescente in una buona parte dell’eurozona.
La strategia prevalente del ceto dirigente tedesco di fronte alla crisi dell’euro e del suo assetto politico-istituzionale è ormai piuttosto chiara. Gekaufte Zeit, tempo comprato, secondo l’espressione adoperata nel magistrale lavoro di Wolfgang Streeck sugli affanni del capitalismo finanziario e sull’insostenibilità dell’euro. L’apertura dei governo tedesco e della BCE all’austerità flessibilità va esattamente in questa direzione, senza prefigurare alcun passo in avanti sostanziale verso la costruzione di una sovranità democratica condivisa dell’eurozona. Nonostante i chiari segnali sull’insostenibilità dell’attuale assetto emersi in diversi Paesi europei nelle elezioni europee del maggio 2014, la nuova legislatura europea è cominciata come se fossimo in una situazione quasi ordinaria, che necessiti al più di una lieve aggiustamento degli indirizzi di politica economica e non di una radicale messa in discussione dell’assetto istituzionale dell’Unione Europea. La sinistra europea sembra accontentarsi di generici impegni a favore di una ‘flessibilizzazione’ dell’austerità, peraltro inevitabile dato la situazione di stagnazione e incipiente deflazione nell’eurozona, e di altrettanto generici richiami al ritorno del metodo comunitario e a un ruolo più forte del Parlamento europeo.
Può sembrare una posizione spiazzante o urticante rispetto al ‘politicamente corretto’ degli ultimi decenni, ma nell’attuale congiuntura europea il nodo non affatto è costituito dal ruolo di un Parlamento o di una Commissione in cui siedono i rappresentanti di dieci paesi che non partecipano al progetto della moneta comune e che allo stato non mostrano alcuna intenzione di aderirvi. La questione cruciale è quella dell’eurozona e della sua trasformazione o meno nell’embrione di una statualità federale, l’unica condizione che forse potrebbe consentire la sopravvivenza della moneta unica.
Preterossi ha richiamato le tesi di Rosanvallon sulla «controdemocrazia» per indicare la necessità di pensare nuove soggettività politiche dal basso, ricollegandosi alle osservazioni di Reichlin. È effettivamente una tema essenziale per la sinistra del nuovo millennio: come ridare forma e protagonismo politica a una nuova umanità che si è plasmata a contatto con la rivoluzione tecnologica, informatica e produttiva dell’ultimo trentennio e che racchiude in sé, assieme a più grandi diseguaglianze e impreviste forme di esclusione, anche nuove possibilità di azione, di accumulo, condivisione e trasmissione del sapere? La questione che pongo, tuttavia, è se questa impresa sia possibile senza restituire a questa nuova umanità, che conosce inedite ma perfino più potenti forme di sfruttamento economico e di marginalizzazione politica, una leva per cambiare l’assetto attuale. E questa leva può non essere un potere in ultima istanza decidente, ossia una sovranità politica a base democratica? Si può davvero pensare di trasformare la moltitudine dei movimenti dal basso in un nuovo popolo democratico se proprio il potere democratico, a differenza di quello finanziario, resta disarmato, privo di due attributi essenziali della sovranità quali la moneta e il bilancio?
È stato lo stesso Rosanvallon ad avanzare assieme a Piketty e ad altri intellettuali francesi, prima delle elezioni europee del 2014, la proposta di superare radicalmente l’attuale assetto dell’Unione Europea e di procedere sulla strada della costruzione di una Camera parlamentare, di un bilancio e di un governo politico-economico dell’eurozona. Si tratterebbe di qualcosa di più dell’embrione di quella che si è definita una statualità federale dei Paesi dell’euro o, almeno, di un primo consistente nucleo all’interno di essi. Un’utopia? Probabilmente sì. Anzi, quasi certamente sì, se si osservano con lucidità e disincanto gli sviluppi politici reali, e non quelli desiderati, dopo le elezioni tedesche del 2013 e quelle europee del 2014. Ma con meno di questa utopia l’attuale assetto europeo è destinato a rivelarsi in modo sempre più evidente non solo una fabbrica di disoccupazione e di insostenibili diseguaglianze sociali e territoriali, ma soprattutto un pericoloso dispositivo di espropriazione e sterilizzazione dei poteri democratici.
Ci stiamo avvicinando al momento in cui bisognerà uscire dall’evocazione del ‘dover essere’ riguardo l’Europa che vorremmo e guardare in faccia fino in fondo l’Europa che c’è. A meno di una svolta profonda e oggi del tutto improbabile nel corso politico europeo, la sinistra, se vorrà ricostruire un rapporto con gli interessi dei ceti popolari, non potrà sottrarsi al tema di una ri-nazionalizzazione di parte consistente delle politiche oggi trasferite a livello europeo, compresa la riappropriazione a livello statuale della sovranità monetaria e di bilancio. Se, come pare ormai evidente, nel fuoco dell’attuale crisi la prospettiva di trasformare l’unione monetaria in una vera unione politica federale diventerà sempre più velleitaria, una sinistra che non si ponesse il problema di una ricostruzione dei poteri di intervento e di azione dello Stato nazionale sarebbe davvero destinata a consegnare definitivamente non solo i ceti popolari (come già in larga parte avvenuto), ma la bandiera stessa della sovranità popolare alla destra populista. D’altra parte, se oggi la qualificazione di populista è diventata l’opposto di un certo europeismo edificante, fatto di buone intenzioni ma pure di una sostanziale difesa dell’attuale assetto europeo (e, quindi, più o meno consapevolmente, degli interessi finanziari che da esso ricevono protezione), allora forse è giunto il tempo di un sano populismo non regressivo di ispirazione democratica, che faccia del rifiuto del paternalismo tecnocratico e della neutralizzazione della sovranità popolare il suo presupposto irrinunciabile. Senza di questo, nella concreta congiuntura storica in cui siamo, ogni discorso sulla rappresentanza e sulla costruzione di nuove forme di soggettività politica oscilla nel vuoto, quell’enorme vuoto di sovranità democratica e di decisione politica prodotto dalla forma attuale dell’Europa e della sua moneta unica.
Contributo presentato al Convegno “Ripensare la cultura politica della Sinistra. Una riflessione sulle idee-forza: la ricostruzione dello Stato”, Roma 26-27 giugno 2014.